I danni causati da Poggiolini all’industria del farmaco

E’ stato ritrovato nelle scorse settimane presso la Banca d'Italia un baule contenente un Tesoro del valore di 26 milioni di euro di proprietà di Duilio Poggiolini, il deus ex machina dello scandalo sui farmaci, in quanto direttore del servizio farmaceutico del Ministero della Salute e responsabile, in accordo col ministro, della fissazione del prezzo dei farmaci.
Vincenzo Atella ne ripercorre sull’Huffington Post, con particolare riferimento alla ricerca e alle ripercussioni sull’industria farmaceutica, l’iter di quella triste vicenda. Per dare un'idea delle dimensioni del fatturato prodotto da questa attività di corruzione, dice Atella, basti ricordare che, a seguito dello scandalo, in un solo anno il giro d'affari della farmaceutica pubblica (quella acquistata dallo Stato) diminuì del 35%, ovvero oltre 4.500 miliardi di lire dell'epoca. Ovviamente, Poggiolini e De Lorenzo (ministro della Salute dell'epoca) erano solo la punta di un iceberg di una vasta rete di corruzione e malasanità che riguardava un nutrito gruppo di persone, composto da medici, proprietari, manager e dipendenti di aziende farmaceutiche, direttori di Asl, professori universitari e consulenti di vario tipo. Insomma, un ampio spaccato di società civile italiana che per oltre un decennio ha munto una mucca che sembrava fornire latte all'infinito, senza fare troppi sforzi. Lo scandalo Poggiolini si inserì poi nel più ampio fenomeno di tangentopoli, e fu archiviato come un caso di corruzione e malasanità, uno dei tanti della storia di questi Paese. Ancora oggi, quando se ne parla, il focus è sullo sperpero dei soldi e sulle morti causate dagli emoderivati infetti. De Lorenzo, tra l’altro, proprio nei giorni scorsi ha plaudito all’imposizione della Ue di rimborsare i danni agli infettati da trasfusioni che egli stesso aveva causato. Ma torniamo ad Atella: a mio avviso, il vero danno creato da quella inopportuna e scellerata gestione va ritrovato nell'aver minato dalle fondamenta le capacità di innovazione dell'industria farmaceutica italiana in un momento in cui nel resto del mondo il settore cambiava pelle e nuove sfide si ponevano. Se per oltre 10 anni il profitto lo si era fatto semplicemente portando "mazzette" a chi deve autorizzare il rimborso di un farmaco o decidere del suo prezzo, a che serve investire in ricerca e sviluppo? Qualcuno forse ricorderà il caso Fidia, il cui fatturato era quasi interamente basato su un principio attivo (i gangliosidi), che successivamente allo scandalo la Commissione Unica del Farmaco definì al meglio "acqua fresca". Ma la Fidia non era l'unico caso. Tra i primi venti farmaci venduti, sei non avevano un'adeguata documentazione che provasse il loro ruolo terapeutico: gangliosidi, carnitina e acetilcarnitina, timopentina, citicolina, timostimolina, ubidecarenone. Da soli questi sei principi attivi superavano i 2 mila miliardi di lire: circa un sesto del totale della spesa farmaceutica in Italia. I vari sistemi di determinazione dei prezzi che si sono succeduti fino alla metà degli anni 90 in Italia non hanno certo aiutato il sistema farmaceutico in un contesto di lungo periodo. Il sistema di corruzione che si era determinato intorno a questo meccanismo ha generato danni incalcolabili per il sistema farmaceutico italiano. A parte il costo puramente finanziario che la collettività ha dovuto subire dovendo acquistare per anni medicinali a prezzi gonfiati, il vero costo è stato quello di aver abituato un sistema farmaceutico italiano a fare profitti in modo sbagliato, distruggendo così molte delle "competences" relative all'attività di ricerca e sviluppo che erano state accumulate negli anni.
Se l’articolo ti è piaciuto inoltralo ad un collega utilizzando l’apposita funzione
pubblicità
Fonte: Huffington Post
I Correlati
Alzheimer, Lilly lancia la campagna di sensibilizzazione “Pensaci. Per non dimenticarlo”
Nel nostro Paese sono 3 milioni i cari che li assistono e si accorgono dei primi segnali della malattia, spesso subdoli da identificare, anche se intervenire precocemente offre nuove opportunità per rallentarne la progressione
Per l'IA le aziende puntano sulle abilità neurodivergenti
Axa, 25% società Fortune 500 userà skill di persone autistiche
Dalla sindrome dell'impostore all'incertezza, le realtà affrontate dalle start up nel settore sanitario
Secondo le loro testimonianze, gli imprenditori spesso si sentono abbandonati, sperimentano la Sindrome dell'Impostore e le scarse opportunità di incontrare i diversi stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione
Al via il programma Fertility Benefit di Merck: favorire la genitorialità per il benessere dei dipendenti e della società
Il Programma Fertility Benefit risponde all’attenzione da sempre dedicata da Merck ai propri dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, all’insegna del benessere e della condivisione
Ti potrebbero interessare
Alzheimer, Lilly lancia la campagna di sensibilizzazione “Pensaci. Per non dimenticarlo”
Nel nostro Paese sono 3 milioni i cari che li assistono e si accorgono dei primi segnali della malattia, spesso subdoli da identificare, anche se intervenire precocemente offre nuove opportunità per rallentarne la progressione
Per l'IA le aziende puntano sulle abilità neurodivergenti
Axa, 25% società Fortune 500 userà skill di persone autistiche
Dalla sindrome dell'impostore all'incertezza, le realtà affrontate dalle start up nel settore sanitario
Secondo le loro testimonianze, gli imprenditori spesso si sentono abbandonati, sperimentano la Sindrome dell'Impostore e le scarse opportunità di incontrare i diversi stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione
Al via il programma Fertility Benefit di Merck: favorire la genitorialità per il benessere dei dipendenti e della società
Il Programma Fertility Benefit risponde all’attenzione da sempre dedicata da Merck ai propri dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, all’insegna del benessere e della condivisione



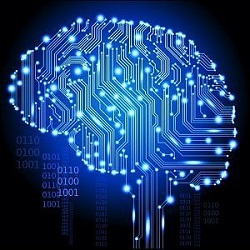


Commenti