La terapia con testosterone ed il carcinoma prostatico
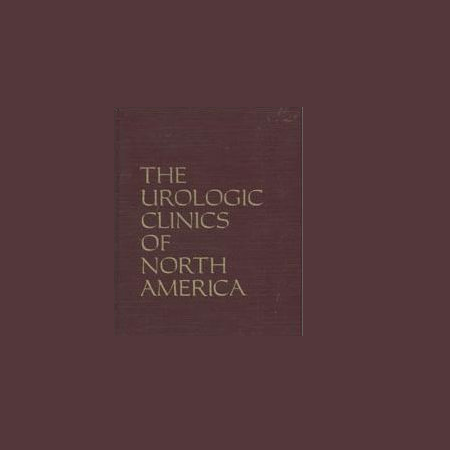
Emily Davidson, Abraham Morgentaler
Evidenze consistenti contraddicono la usuale credenza sull’uso di testosterone e cancro prostatico.
La storia del testosterone parte nel 1849 grazie agli studi condotti sull’animale da Arnold Berthold e passa attraverso diversi fasi sperimentali che hanno via via dimostrato le proprietà dell’ormone ed il suo ruolo nella pratica clinica. Tuttavia poco dopo la sua introduzione in commercio come preparato terapeutico fu pubblicato un lavoro di Huggins e Hodges che riporta un possibile beneficio della castrazione su metastasi ossee in soggetti con tumore prostatico. Da quel momento, era il 1941, l’uso di testosterone (T) diventò occasionale a causa del timore di cancro prostatico: prima degli anni ‘90 era, infatti, raro e limitato a giovani maschi con gravi casi di ipogonadismo, dovuti a tumori ipofisari, anorchia o anomalie genetiche.
pubblicità
Sebbene il T sia disponibile come preparato terapeutico da oltre 80 anni, l’introduzione nel mercato negli ultimi 10 anni di formulazioni più sicure e maneggevoli, ha permesso una più ampia diffusione della terapia con T in soggetti ipogonadici, permettendo di sfruttare gli importanti benefici da essa derivati, pur garantendo la sicurezza ed in particolare il rischio di cancro prostatico.
E’ da oltre 70 anni che a studenti ed medici è stato insegnato che elevati livelli di T promuovono ca-prostatico, col timore di “gettar benzina sul fuoco”, visto che il tumore prostatico è androgeno-dipendente.
Negli ultimi tempi questa convenzionale visione è stata riconsiderata, in particolare dopo che nel 2004 è stato messo in luce che bassi livelli di T possano essere fattori di rischio per cancro prostatico più aggressivo - e non protettivi - per insorgenza e progressione.
Ad oggi, in oltre 20 studi longitudinali di popolazione, inerenti a più di 20.000 pazienti con un follow up medio di oltre 10 anni, non è stata dimostrata la relazione tra carcinoma prostatico e androgeni sierici. Allo stesso modo 7 studi di meta-analisi non hanno documentato alcuna relazione tra terapia con T e rischio di tumore prostatico.
I dati attuali pertanto escludono una relazione tra T endogeno o esogeno e lo sviluppo di ca-prostatico, come anche rilevato in una recente review. Per chiarire, in questo articolo gli Autori ribadiscono che la relazione tra T e prostata si basa su un modello detto “di saturazione”, oggi per lo più condiviso, secondo cui il tessuto prostatico è particolarmente sensibile a variazioni di bassi livelli di T in condizioni di ipogonadismo, ma diventa irresponsivo col raggiungere concentrazioni di eugonadismo. La esposizione a concentrazioni crescenti di androgeni causa crescita tissutale che raggiunge quindi un plateau a concentrazioni limite (coincidenti con quelle del ritorno ad un eugonadismo) a seguito di una saturazione dei recettori per il T espressi sulle cellule prostatiche . Ulteriori aumenti dei livelli circolanti di T non determinano ulteriori cambiamenti del tessuto prostatico. A questo meccanismo sottendono razionali biologici ampiamente descritti. Quindi, il T non appare “benzina sul fuoco” .
Tuttavia è importante che il medico conosca sia i benefici del trattamento con T che la condizione clinica del paziente e valuti i rischi.
Uno dei temi più dibattuti ad oggi riguarda la possibilità di trattare con T pazienti ipogonadici con una storia pregressa di ca-prostatico. In tali casi i dati disponibili sono scarsi e il paziente dovrà essere adeguatamente informato (e richiesto consenso) sui rischi e benefici nel caso si decida di instaurare un trattamento a base di T. Una terapia con T in questi pazienti si ritiene possibile allorchè il paziente sia considerato “a basso rischio” con PSA non rilevato dopo chirurgia o con ottima risposta alla radioterapia. Viceversa sarebbero da escludere i soggetti ad alto rischio in relazione alla diagnosi istologica, oltre a quelli che già presentano un tumore avanzato o metastatico e sono trattati con deprivazione androgenica. La terapia con il testosterone potrebbe quindi essere considerata solo per alcuni uomini con storia di cancro prostatico, previa autorizzazione del paziente e nel caso in cui sia garantito un adeguato monitoraggio.
In generale un counseling adeguato prima di una terapia con T sarà comunque sempre opportuno, come pure durante tutto il periodo di trattamento.
Recenti e consistenti attuali evidenze scientifiche concordano sul fatto che alti livelli dell’ormone non siano associati ad un aumentato rischio di sviluppare il tumore o ad un più elevato Gleason. Il modello di saturazione può spiegare invece il maggior rischio in presenza di basse concentrazioni di T.
L’uso della terapia con T in soggetti con storia di Ca-prostatico non dovrebbe più essere considerata una controindicazione assoluta, seppur valutata con grande attenzione in assenza di dati conclusivi.
In conclusione, negli ultimi 20 anni si è avviata una rivoluzione nelle conoscenze e nella pratica riguardo a testosterone e carcinoma prostatico.
Fonte:
Emily Davidson and Abraham Morgentaler. Testosterone Therapy and Prostate Cancer. Urol Clin N Am 43 (2016) 209–216.
A.N. L.IT.COM.04.2017.2366
Data di deposito AIFA: 7 aprile 2017
I Correlati
Tumore alla prostata avanzato: la partecipazione attiva dei pazienti migliora il percorso di cura
I risultati della ricerca condotta da Elma Research sui pazienti italiani con carcinoma prostatico metastatico fanno emergere tre profili di pazienti: il Tormentato (28%),il Fatalista (42%) e il Risolto (30%)
Tumore alla prostata, cosa c'è da sapere
Novembre è dedicato alla prevenzione, è il tipo più frequente fra gli uomini
Tumore alla prostata: rimossa con robot, IA e realtà aumentata
All'Irccs Candiolo, maggiore efficacia e recupero più veloce
Tumore della prostata: rimborsata nuova terapia per le forme con mutazioni BRCA
È rimborsata in Italia la compressa a doppia azione a base di niraparib e abiraterone acetato in associazione con predniso(lo)ne per il trattamento di pazienti adulti con tumore della prostata metastatico e resistente alla castrazione
Ti potrebbero interessare
Tumore del pancreas, mix di farmaci generici potenzia la chemioterapia
Sono un antiepilettico e un farmaco per il colesterolo che insieme sono in grado di modificare la biologia del tumore e potenziare l'effetto della chemioterapia
L'immunoterapia aumenta la sopravvivenza in un numero crescente di tumori
Dal melanoma al seno. Da studiare il fenomeno della resistenza in certi pazienti
Come sfruttare la vulnerabilità del cancro per nuove terapie
Ricercatori di IEO e dell’Università degli Studi di Milano scoprono come farmaci già in uso possono essere potenzialmente efficaci contro tumori con una diffusa anomalia genetica
Novità per il tumore del polmone non a piccole cellule con mutazione dell’EGFR dagli studi Mariposa e Mariposa-2 su amivantamab
I nuovi dati dello studio MARIPOSA, presentati alla World Conference on Lung Cancer 2024, hanno confermato una superiorità clinica a lungo termine della terapia amivantamab più lazertinib rispetto alla monoterapia con osimertinib






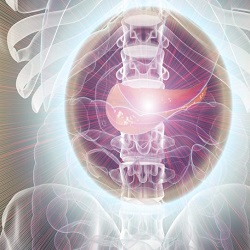




Commenti