Da L’Espresso: Farmaci da buttare
È una curva che scende, inesorabilmente e repentinamente. Da anni. Quella che riassume il numero delle molecole studiate dai grandi gruppi farmaceutici che riescono a raggiungere il mercato. E questo nonostante la montagna di soldi che le aziende investono ogni anno nella ricerca di nuove medicine. Che, il più delle volte, non superano lo stadio di 'molecole promettenti'e poi spesso si arenano alla prova finale della sperimentazione, nella quale si deve dimostrare che la 'molecola promettente' non solo funziona in laboratorio e sugli animali, non solo non è tossica, ma deve combattere efficacemente la malattia nell'uomo. Negli ultimi anni un buon numero di annunciati 'blockbuster' sono finiti così in soffitta. E Big Pharma cerca in tutti i modi di porre rimedio a una crisi che non è solo finanziaria, ma anche e soprattutto di prodotti. Una crisi che subirà un'accelerazione nel 2010, quando cominceranno a scadere decine di brevetti sui medicinali che negli ultimi quarant'anni hanno prodotto fatturati giganteschi.
Andrew Hopkins la crisi della ricerca farmaceutica l'ha vissuta in prima persona proprio dentro il più grosso dei colossi industriali del settore, l'americana Pfizer, e oggi lavora nella Division of Biological Chemistry and Drug Discovery all'Università di Dundee in Scozia. E in vent'anni si è fatto un'idea molto precisa di cosa sta accadendo e di come si può uscire dalla crisi. Ne ha parlato durante il convegno internazionale 'Network Pharmacology: nuovi indirizzi nello sviluppo dei farmaci' promosso dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con la Fondazione Sigma-Tau, dove l'abbiamo incontrato.
Professor Hopkins, perché la farmacologia moderna è arrivata a un punto morto?
pubblicità
"La strategia del bersaglio specifico, o se si vuole dei proiettili intelligenti, quella per cui il farmaco doveva essere sviluppato per colpire un solo meccanismo della cellula malata ha funzionato molto bene per decenni, ma ora sta mostrando tutta la sua debolezza. Ci scontriamo ormai con un paradosso: accumuliamo sempre maggior conoscenza e abbiamo a disposizione una tecnologia sempre più sofisticata, eppure non riusciamo a scoprire nuovi farmaci efficaci. Basti pensare che il 76 per cento dei farmaci sviluppati negli ultimi 20 anni colpiscono bersagli scoperti più di 30 anni prima, e che solo il 6 per cento dirige la sua azione su recettori svelati recentemente. Un altro dato da considerare è che il 40 per cento dei guadagni delle aziende farmaceutiche deriva da vendite di farmaci off label, usati per altre indicazioni rispetto a quelle per cui sono stati registrati. La medicina selettiva è quindi solo un mito. È evidente che dobbiamo cambiare strada".
Come?
"Anziché all'azione specifica di una molecola in un unico punto bisognerà puntare su quella combinata su differenti bersagli. È giunto il momento di pensare in termini di 'multi target drugs', medicinali che mirano a modificare il sistema di interazioni fra proteine che sta dietro lo sviluppo di una condizione patologica. Una strada è quella della polifarmacologia o farmacologia di rete".
In cosa consiste?
"Nella ricerca di farmaci che si leghino specificamente a due o più bersagli molecolari. Che questa sia una strada obbligata ce lo dimostrano anche alcuni casi di composti scoperti negli ultimi anni. Per esempio la nuova generazione di farmaci antitumorali che colpiscono molecole specifiche (come le proteine chinasi ABL, EGFR e ERBB2) che si trovano espresse in modo differente in molti tipi di cancro. Si tratta di proteine che non sono essenziali per le cellule; e infatti i farmaci che le colpiscono provocano meno effetti collaterali dei chemioterapici tradizionali, ma anche il loro effetto è limitato. Il problema è che le proteine presenti nelle cellule cancerose sono per buona parte le stesse che ritroviamo in quelle sane: colpirle significa quindi indebolire tutte le cellule indiscriminatamente. Ma a cambiare nella cellula malata potrebbero essere le interazioni fra queste sostanze. Ecco allora che il nostro nuovo bersaglio non saranno più le proteine, ma il modo in cui queste si combinano e interagiscono, la loro rete di relazioni. Per esempio, sappiamo che ad aumentare le probabilità che si sviluppino metastasi nel cancro al seno è l'azione congiunta di quella che è stata chiamata la 'compagnia delle quattro', quattro molecole. Per scoprire queste combinazioni ci sono voluti decenni di studi: ora grazie alla teoria delle reti e alla potenza di calcolo raggiunta dai computer siamo in grado di essere molto più efficaci e veloci".
Che cosa ha imparato la farmacologia dalla scienza delle reti?
"A considerare l'importanza di un target non solo in base all'effetto della sua inibizione, ma anche a partire dalla sua centralità rispetto a tutti gli altri target che compongono il sistema. Nella teoria delle reti si parla di 'nodi': se voglio danneggiare un sistema devo colpire i nodi più significativi, quelli attraverso cui passano più interazioni, o quelle più importanti. I sistemi biologici sono reti complesse e dobbiamo agire alla stessa maniera: capire quali sono i nodi sensibili e colpirli, magari anche debolmente, ma tutti insieme in modo da scardinare la rete. Il nostro obiettivo però non è avere un farmaco che colpisce molti target, ma disegnare razionalmente una molecola che colpisca più di un bersaglio nella maniera più giusta".
In che modo è possibile raggiungere questo obiettivo?
"Con il mio team di ricerca abbiamo appena brevettato un metodo informatico di ottimizzazione del calcolo per la scoperta di nuove molecole. Per ora i nostri studi si sono concentrati prevalentemente sugli antipsicotici: è una classe di medicinali su cui è stata fatta molta ricerca chimica. E se devi insegnare a un computer a masticare dati bisogna iniziare da dove questi sono più sostanziosi. In più si tratta di un ottimo esempio di terapia che colpisce molti recettori ed è esemplificativo di un effetto complesso: si tratta di farmaci potenzialmente in grado di modulare sia l'umore sia le capacità cognitive. E non esiste un singolo gene o target da cui dipende questa azione, ma è un insieme di recettori e proteine che contribuiscono a differenti livelli all'effetto finale. È quindi un campo di applicazione ottimo per testare questo approccio".
Oltre alle malattie psichiche, quali sono le patologie che potranno essere curate da queste multi target drugs?
"Malattie complesse come quelle cardiovascolari, il diabete, il cancro. Proprio dalla gestione clinica di queste patologie risulta infatti chiaro che il sogno a lungo accarezzato di poter trovare i geni associati in maniera univoca a queste condizioni non potrà mai essere realizzato. Ce ne sono centinaia, e ognuno contribuisce per una piccola parte al quadro clinico. Si tratta quindi di malattie di rete e per curarle dobbiamo prendere in considerazione l'intrigata geografia delle interazioni proteiche che le caratterizzano. D'altronde già lo facciamo con buoni risultati, ma a posteriori, con le terapie di combinazione per l'Aids, il cancro o l'arteriosclerosi, anche se i limiti di questo approccio sono evidenti".
Sta parlando delle multiterapie?
"La strategia convenzionale è quella di prescrivere al paziente più di un farmaco, ma questo comporta problemi di aderenza alla terapia. Poi c'è la strada di mettere più principi attivi all'interno di una stessa compressa, ma ci si scontra con le differenti caratteristiche chimiche dei farmaci che pongono dei problemi sia in termini di efficacia sia di effetti collaterali. E infine c'è la terza via, che agisce a monte: riuscire a disegnare un singolo composto grazie alla polifarmacologia. Una strada vincente anche in termini di risparmio per le aziende".
Perché?
"Se si deve dimostrare l'efficacia di una terapia combinata sono necessari i dati dei singoli componenti, così come quelli della combinazione. Ma se si tratta di un solo composto che colpisce più bersagli allora abbiamo bisogno di prove di sicurezza ed efficacia solo per quello. Per le aziende sarebbe sicuramente conveniente, anche perché dalla combinazione di due composti può nascere anche più di un farmaco".
I Correlati
Alzheimer, Lilly lancia la campagna di sensibilizzazione “Pensaci. Per non dimenticarlo”
Nel nostro Paese sono 3 milioni i cari che li assistono e si accorgono dei primi segnali della malattia, spesso subdoli da identificare, anche se intervenire precocemente offre nuove opportunità per rallentarne la progressione
Per l'IA le aziende puntano sulle abilità neurodivergenti
Axa, 25% società Fortune 500 userà skill di persone autistiche
Dalla sindrome dell'impostore all'incertezza, le realtà affrontate dalle start up nel settore sanitario
Secondo le loro testimonianze, gli imprenditori spesso si sentono abbandonati, sperimentano la Sindrome dell'Impostore e le scarse opportunità di incontrare i diversi stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione
Al via il programma Fertility Benefit di Merck: favorire la genitorialità per il benessere dei dipendenti e della società
Il Programma Fertility Benefit risponde all’attenzione da sempre dedicata da Merck ai propri dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, all’insegna del benessere e della condivisione
Ti potrebbero interessare
Alzheimer, Lilly lancia la campagna di sensibilizzazione “Pensaci. Per non dimenticarlo”
Nel nostro Paese sono 3 milioni i cari che li assistono e si accorgono dei primi segnali della malattia, spesso subdoli da identificare, anche se intervenire precocemente offre nuove opportunità per rallentarne la progressione
Per l'IA le aziende puntano sulle abilità neurodivergenti
Axa, 25% società Fortune 500 userà skill di persone autistiche
Dalla sindrome dell'impostore all'incertezza, le realtà affrontate dalle start up nel settore sanitario
Secondo le loro testimonianze, gli imprenditori spesso si sentono abbandonati, sperimentano la Sindrome dell'Impostore e le scarse opportunità di incontrare i diversi stakeholder dell'ecosistema dell'innovazione
Al via il programma Fertility Benefit di Merck: favorire la genitorialità per il benessere dei dipendenti e della società
Il Programma Fertility Benefit risponde all’attenzione da sempre dedicata da Merck ai propri dipendenti, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, all’insegna del benessere e della condivisione



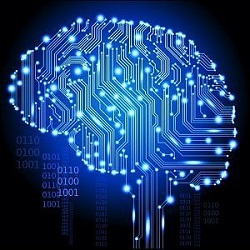


Commenti