Nuove strategie nella gestione dello scompenso cardiaco: la medicina rigenerativa.

La ricerca di terapie emergenti e di soluzioni basate sulla medicina di precisione per la gestione dello scompenso cardiaco non rappresenta solo una sfida scientifica, ma anche un imperativo morale.1
Abstract
Lo scompenso cardiaco è una sindrome complessa e multifattoriale, che rappresenta un significativo problema della salute globale. Sebbene i trattamenti attuali, inclusi interventi farmacologici, terapie con dispositivi e modifiche dello stile di vita, abbiano migliorato gli esiti per molti pazienti scompensati, essi presentano ancora limiti significativi. Da qui deriva la pressante necessità di un’innovazione continua che possa affrontare le molteplici sfide poste da questa patologia. I continui progressi nella gestione dello scompenso cardiaco alimentano nuove speranze per i pazienti, grazie a soluzioni all’avanguardia che spaziano da interventi farmacologici innovativi e dispositivi avanzati, alla medicina rigenerativa e alle cure di precisione. Questa minireview riprende in parte l’intricato panorama delle terapie emergenti per lo scompenso, sottolineando tanto il loro potenziale quanto i loro limiti.
pubblicità
Lo scompenso cardiaco, o insufficienza cardiaca, rappresenta una sfida crescente per la salute globale, colpendo milioni di persone in tutto il mondo. [1] Si tratta di una sindrome complessa, che può derivare da numerose eziologie, come cardiopatia ischemica, ipertensione, anomalie valvolari e cardiomiopatie.[1] Tradizionalmente, la gestione dell’IC si è concentrata sull’alleviamento dei sintomi, sulla riduzione della ritenzione di liquidi e sul miglioramento della contrattilità cardiaca, obiettivi raggiunti grazie a terapie farmacologiche, come gli ACE-inibitori, i β-bloccanti e i diuretici, spesso integrate da dispositivi come i defibrillatori cardioverter impiantabili e la terapia di resincronizzazione cardiaca.[1] Nonostante questi progressi, l’inesorabile evoluzione dell’IC rimane una sfida clinica significativa.[1] Processi complessi, quali l’attivazione neuro-ormonale, la fibrosi cardiaca e il rimodellamento cellulare contribuiscono infatti alla sua progressione.[1]
Terapia genica ed editing genomico
Negli ultimi anni, l’attenzione si è spostata verso l’identificazione di nuovi approcci terapeutici che affrontino i meccanismi alla base dell’IC. [1] Tra questi, la terapia genica ha suscitato particolare interesse, grazie a promettenti tecniche di editing genico, le quali offrono potenziali vie per correggere le mutazioni genetiche che contribuiscono all’insufficienza cardiaca.[1] In particolare, l’editing del genoma ha il potenziale di correggere in modo permanente le varianti patogene loss-of-function e gain-of-function associate all’IC e alla cardiomiopatia.[2] Ad esempio, il sistema CRISPR-Cas9, che è stato insignito del premio Nobel nel 2020, ha generato un grande entusiasmo in campo medico,[3] al punto da essere riproposto non solo per l’editing del genoma delle cellule somatiche, ma anche per modulare l’assetto epigenomico delle cellule.[2] In due recenti studi condotti da gruppi indipendenti, l’editing delle basi adeniniche con CRISPR-Cas9 è stato utilizzato con successo per prevenire lo sviluppo e la progressione della cardiomiopatia ipertrofica in modelli murini ben consolidati.[2]
Strategie rigenerative: terapia cellulare e xenotrapianto
Per i pazienti con IC in fase terminale, il trapianto di cuore rimane l’unica terapia curativa definitiva.[3] Tuttavia, la limitata disponibilità di organi ha portato allo sviluppo di terapie rigenerative o sostitutive.[3] La terapia cellulare, introdotta nei primi anni 2000, ha dimostrato la sicurezza e la fattibilità dell’utilizzo di cellule staminali, sia autologhe sia allogeniche, per il trattamento dello scompenso cardiaco.[1] Inoltre, diversi studi hanno riportato miglioramenti funzionali nei pazienti scompensati, trattati con cellule staminali, tra cui: un aumento della LVEF (left ventricular ejection fraction, frazione di eiezione ventricolare sinistra), una riduzione del rimodellamento ventricolare e una maggiore capacità di esercizio.[1]
Un’altra opzione che permetterebbe di evitare il trapianto allogenico di cellule e di compensare la scarsa disponibilità di organi di donatori è lo xenotrapianto; questo potrebbe infatti fornire una fonte illimitata di cellule e organi.[3] Gli organi provenienti da maiali geneticamente modificati, ad esempio, offrono nuove speranze per la sostituzione degli organi e la terapia rigenerativa.[3]
Invece, il primo impianto di un cuore artificiale totale (TAH, Total Artificial Heart) è stato eseguito 50 anni fa e oggi rappresenta una valida strategia per fornire supporto ai pazienti con insufficienza biventricolare, in attesa del trapianto di cuore.[3] Il nuovo dispositivo Aeson TAH (A-TAH), sviluppato in Francia, testato per la prima volta sull’uomo nel 2013, ha ottenuto il marchio CE in Europa ed è attualmente in fase di sperimentazione clinica negli Stati Uniti.[3] Tutte le superfici del dispositivo a contatto con il sangue sono emocompatibili; inoltre, le membrane all’interno dei ventricoli sono costituite da pericardio bovino, già utilizzato negli ultimi 30 anni per le valvole bioprotesiche.[3] La fissazione di questo tessuto xenogenico con glutaraldeide ne ha ridotto ulteriormente l’immunogenicità.[3]
Le cellule staminali, il cuore artificiale e gli xenotrapianti rappresentano, quindi, delle soluzioni promettenti per affrontare la carenza di donatori di organi.[3] Tuttavia, ulteriori ricerche accademiche e studi preclinici saranno necessari per valutare in modo più approfondito le potenziali complicanze, come l’immunotrombosi e i danni a organi e vasi sanguigni, e per trasformare questa prospettiva in una realtà clinica.[3]
Verso il futuro: terapie combinate e personalizzazione
La combinazione di cellule staminali con biomateriali e tecniche di ingegneria tissutale è un approccio promettente per la creazione di patch o costrutti cardiaci funzionali.[1] Questi tessuti ingegnerizzati potrebbero riparare il miocardio danneggiato e migliorare la funzione cardiaca.[1] Inoltre, le ricerche emergenti stanno esplorando le potenziali sinergie tra la terapia con cellule staminali e altri approcci innovativi, come la terapia genica, i fattori di crescita o gli agenti farmacologici.[1] Queste terapie combinate mirano a potenziare gli effetti rigenerativi e a migliorare i risultati clinici, aprendo nuove strade nella medicina rigenerativa per il trattamento delle malattie cardiache.[1]
Con il progredire della ricerca e l’esplorazione di nuove strategie terapeutiche, la speranza è che la gestione dello scompenso cardiaco diventi sempre più personalizzata, efficace e accessibile, migliorando in ultima analisi la qualità della vita e la prognosi delle persone colpite da questa sindrome debilitante.[1]
Bibliografia:
- Sapna F, Raveena F, Chandio M, et al. Advancements in Heart Failure Management: A Comprehensive Narrative Review of Emerging Therapies. Cureus. Oct 2023;15(10):e46486. doi:10.7759/cureus.46486
- Johnston JR, Adler ED. Precision Genetic Therapies: Balancing Risk and Benefit in Patients with Heart Failure. Curr Cardiol Rep. Sep 2024;26(9):973-983. doi:10.1007/ s11886-024-02096-5
- Smadja DM. Stem Cell Therapy, Artificial Heart or Xenotransplantation: What will be New "Regenerative" Strategies in Heart Failure during the Next Decade? Stem Cell Rev Rep. Apr 2023;19(3):694-699. doi:10.1007/s12015-022-10476-z
I Correlati
Pubblicate le nuove Linee guida europee sull'arresto cardiaco
Sul Resuscitation Journal le nuove indicazioni realizzate grazie al lavoro di 150 esperti di 29 paesi, che sottolineano il ruolo delle persone comuni nella gestione degli arresti cardiaci
Intelligenza artificiale nello scompenso cardiaco: verso una medicina predittiva e personalizzata.
Marketing farmaceutico, volevate un nuovo libro? Ora c’è. La presentazione il 21 novembre a Milano
Rimborsabile mirikizumab contro la colite ulcerosa
Via libera da Aifa, riduce i sintomi intestinali senza l'uso di steroidi
Ti potrebbero interessare
La difficile gestione del paziente con basso status socioeconomico affetto da HF
Scompenso cardiaco: gestione del paziente in seguito alla dimissione ospedaliera
Diagnosi e gestione dello scompenso cardiaco in gravidanza
Prevenzione e gestione del paziente con scompenso cardiaco




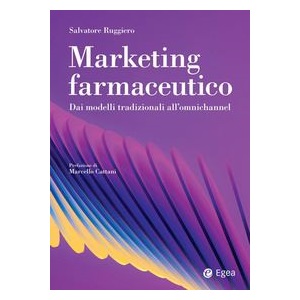






Commenti